
La vicenda è iniziata quando una coppia di cuffie Beats di Apple è esplosa durante un volo. La notizia è stata riportata da una donna che ha postato una foto delle cuffie sui social media. La donna ha affermato che le cuffie si sono incendiate durante il volo, ma che fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La donna ha anche affermato che le cuffie erano collegate a una batteria esterna.
Per Saperne Di Più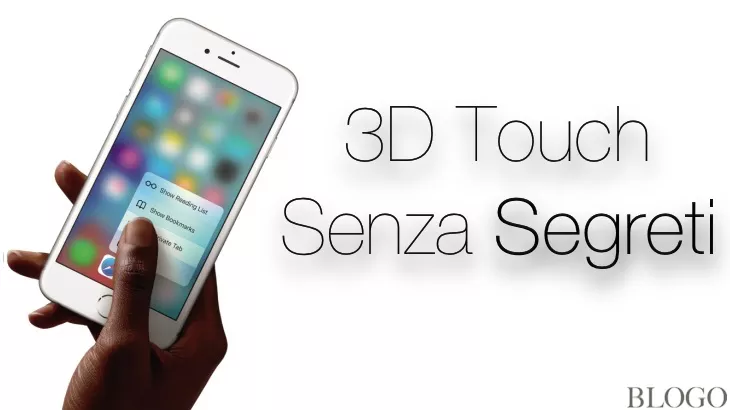
L'iPhone 6s è dotato di una vasta gamma di funzionalità che lo rendono uno dei dispositivi più versatili sul mercato. Tra le sue principali funzionalità ci sono:
Per Saperne Di Più